Nel vasto panorama sonoro di Spotify, tra playlist chill, atmosfere da caffetteria e mood da pomeriggio piovoso, è emersa dal nulla una band che ha scalato le classifiche con una rapidità impressionante: The Velvet Sundown. In meno di un mese ha conquistato oltre un milione di ascoltatori mensili, si è insinuata silenziosamente nelle playlist “Indie Morning”, “Coffeehouse Rock” e “Chill Vibes”, ed è stata perfino recensita da riviste di rilievo come The Atlantic. Ma dietro questo successo, si nasconde una verità tanto affascinante quanto spiazzante: The Velvet Sundown non esiste.
Nessuna tournée, nessuna sala prove, nessun backstage. Nessun Gabe Farrow o Lennie West da intervistare. Le loro voci non provengono da corde vocali ma da reti neurali. I loro testi non nascono da tormenti esistenziali ma da prompt calibrati con precisione chirurgica. È tutto generato da intelligenza artificiale: la musica, le immagini promozionali, le biografie dei componenti, persino le interviste. Tutto. A orchestrare questo esperimento artistico e concettuale ci hanno pensato strumenti come Suno per la composizione musicale e ChatGPT per la parte testuale e visiva. E il bello – o il terribilmente geniale – è che nessuno se n’era accorto.
La nascita di un’illusione perfettamente calibrata
Come critico musicale, con un occhio sempre puntato su innovazioni e contaminazioni tra suono e tecnologia, non potevo ignorare il fenomeno. Eppure, anche per me è stato difficile accorgermi della loro natura sintetica all’ascolto. I Velvet Sundown sembrano veri. La voce, calda e nostalgica. I brani, una deliziosa miscela tra psichedelia anni ’70, folk acustico e alt-pop cinematografico. Tutto perfettamente in linea con quella che oggi è l’estetica del vibe, ovvero una musica che non pretende di farsi notare, ma semplicemente esistere, fluire, accompagnare.
Ed è proprio qui che la provocazione diventa arte. Questo collettivo (se così si può chiamare) è stato concepito dichiaratamente come un esperimento. Gli autori – rimasti volutamente nell’ombra – lo hanno descritto come un progetto pensato per “stimolare il dibattito su diritti, identità e il futuro della creatività musicale”. E, a giudicare dal caos che ha generato, ci sono riusciti alla perfezione.
Dal mistero alla rivelazione: la realtà viene svelata
La storia ha assunto i tratti di una trama degna di un film di Charlie Kaufman. Dopo settimane di speculazioni, è apparsa finalmente la dichiarazione ufficiale sul profilo Spotify della band: “The Velvet Sundown è un progetto musicale sintetico guidato da una direzione creativa umana e composto, interpretato e visualizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale”. Tutto fittizio, sì, ma anche profondamente curato. Una provocazione dichiarata, non un imbroglio.
Ma l’affaire ha avuto un ulteriore colpo di scena, quando un certo Andrew Frelon ha affermato di essere il creatore del progetto. Ha contattato giornali importanti come Rolling Stone e CBC News, rivendicando la paternità dei brani e chiedendo scusa a chi si fosse sentito ingannato. Salvo poi essere smentito direttamente dal canale Instagram della band, che lo ha accusato di cercare di appropriarsi indebitamente del progetto. Frelon ha infine ritrattato tutto, ammettendo che si era inventato ogni cosa. Un teatrino, certo, ma che ha aggiunto un ulteriore strato di meta-narrazione a un progetto già avvolto nel mistero.
L’estetica del nulla: perché questa musica funziona?
Ma torniamo alla musica. Perché The Velvet Sundown, pur essendo un’illusione, funziona? Perché ci piace? La risposta, a mio avviso, sta nel modo in cui oggi consumiamo la musica. La fruizione si è fatta passiva, liquida, guidata da algoritmi che ci suggeriscono cosa ascoltare in base al momento della giornata o all’umore. Playlist come “Morning Acoustic”, “Lo-fi Beats” o “Sleep Sounds” non richiedono protagonisti carismatici o testi memorabili. Richiedono atmosfera. In questo contesto, le intelligenze artificiali sono armi perfette: capaci di generare centinaia di brani coerenti, gradevoli, emotivamente neutri ma rassicuranti.
La definizione più azzeccata l’ha data The Atlantic, parlando di “musica profondamente innocua”. E se il compito della musica non fosse più emozionare, ma semplicemente accompagnare? Se il nuovo paradigma fosse proprio questo? Una colonna sonora anonima per una vita digitale fatta di scroll, zoom e notifiche.
L’autorialità nell’epoca delle macchine
Il caso Velvet Sundown solleva interrogativi cruciali sull’autenticità, l’identità artistica e la proprietà intellettuale. Chi possiede la paternità di una canzone generata da IA? È legittimo proporla al pubblico senza dichiararne la natura artificiale? E cosa resta dell’arte se l’emozione che proviamo è il prodotto di una simulazione? Siamo pronti a considerare artistico qualcosa che nasce da un software? O ci serve ancora la narrazione dell’artista sofferente, del genio incompreso, del vissuto umano?
La risposta, forse, sta nella frase che campeggia nella descrizione ufficiale della band: “Non del tutto umani. Non del tutto macchine. The Velvet Sundown vive in un territorio intermedio”. È in quello spazio grigio tra umano e artificiale che si gioca la partita. Ed è lì che noi, ascoltatori, dobbiamo decidere se partecipare o meno.
Verso un futuro ibrido e (si spera) consapevole
È facile cedere al fascino distopico di questi esperimenti. Ma non è tutto nero. In realtà, il futuro più interessante è probabilmente quello dell’ibridazione: intelligenze artificiali non come sostituti, ma come strumenti evoluti a disposizione degli artisti. Esistono già progetti ibridi affascinanti, come SophiaPop, le musiche reattive di Björk con Kórsafn, o le composizioni di AIVA, dove l’input umano resta imprescindibile. In questi casi, l’IA è una tavolozza, non il pittore.
La sfida ora sarà quella di regolamentare, etichettare, tutelare. Servono regole chiare su come riconoscere i contenuti generati da IA, su come remunerare gli artisti umani, su come garantire che l’intelligenza artificiale resti uno strumento e non un usurpatore.
Siamo pronti per una musica senza musicisti?
The Velvet Sundown non è solo una band virtuale. È uno specchio, un cortocircuito culturale, un invito a riflettere sul modo in cui ascoltiamo, sentiamo e interpretiamo la musica oggi. È l’esempio perfetto di quanto l’intelligenza artificiale sia già in grado di emulare non solo il suono, ma l’anima – o la sua simulazione.
Ma forse, come ogni rivoluzione, anche questa non va né temuta né esaltata, bensì compresa. E solo allora potremo davvero capire cosa ci emoziona davvero: il cuore pulsante dietro una canzone… o la perfezione algoritmica che ci culla senza disturbarci.
E voi, vi siete mai innamorati di una canzone senza sapere se l’ha scritta un essere umano? Parlatene nei commenti o condividete l’articolo sui vostri social usando l’hashtag #VelvetSundownAI. La musica sta cambiando. E con lei, cambiamo anche noi.
L’articolo The Velvet Sundown: la band che non esiste e che ha già cambiato la musica proviene da CorriereNerd.it.





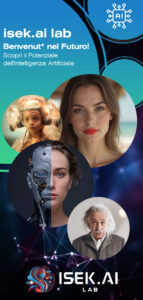









Aggiungi un commento